Il tuo carrello è attualmente vuoto!
Rendere il fast fashion più sostenibile
Published by
on


“La giacca più sostenibile è quella nel tuo armadio”, è quello che si dice. Ma perché non quella nell’armadio di qualcun’altro? E no, non vi stiamo invitando a derubare i vostri amici (e neanche gli sconosciuti).
In un mondo dove sono sempre più diffusi i termini “sostenibile“, “eco-friendly”, “socialmente ed ecologicamente responsabile“1, risulta quasi difficile distinguere le iniziative veramente impegnate su questi temi da quelle che vi sono vicine solo per apparenza. O meglio, per non apparire come i “cattivi” agli occhi di un pubblico sempre più attento a questi temi (almeno all’apparenza).
Perché sì, alla fine molto spesso l’attenzione, sia da parte del pubblico che del privato, risulta puntata su questi temi solo superficialmente, mentre l’interesse diminuisce progressivamente via via che le domande diventano più specifiche. Ti reputi sostenibile? Sì (penso). Proponi iniziative sostenibili dal punto di vista sociale? Certamente. Quale percentuale del tuo lavoro è sostenibile? Tanta, tantissima (10%). Credi nelle iniziative sostenibili in cui investi? Ovvio (che boh). Hai pianificato di aumentarle negli anni? Pensi che abbiano un buon impatto nel mondo? Pensi che siano sufficienti ad almeno compensare le tue emissioni? Ti sei mai preoccupato del “green washing”? Non so neanche cosa sia.
Ebbene, troppo spesso le iniziative sostenibili vengono promosse con il solo scopo di nascondere quelli che sono ormai troppi scheletri nell’armadio.

E molto spesso, purtroppo, per il pubblico questo è sufficiente per dimenticarsi del problema, etichettandolo come uno di quelli la cui soluzione è delegabile ai poteri forti, o comunque sicurmente a quelli più forti di noi. Ed è così che il green washing diventa un lavaggio verde di coscienza collettivo.
Come tutti i cambiamenti, anche questo non può prescindere da un interesse e un impegno da parte di tutti. Per questo motivo, qui proverò a sondare alcune possibili soluzioni alla crescente esigenza collettiva di alternative alla fast fashion.
Le alternative sostenibili dalla fast fashion
Prima di tutto, è doveroso iniziare proprio dai brand di fast fashion, poichè loro in primis propongono alcune soluzioni. Ma sono davvero soluzioni, o sono più palliativi che cure? Chiaramente, la sostenibilità, sia ambientale che sociale ed etica, dovrà essere una delle colonne portanti su cui si baserà il futuro, ma sembra troppo spesso che quella della sostenibilità sia più una maschera che una proposta concreta e utile. Ma veramente è tutto inutile?
A mio parere, no. H&M per esempio distribuisce collezioni dedicate in modo specifico alla produzione etica e sostenibile per quanto riguarda i materiali utilizzati. Questa azienda lavora su una scala talmente grande che anche piccoli cambiamenti nella loro catena produttiva hanno un impatto considerevole. Considerando anche i tempi e le risorse necessari per gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo di alternative sostenibili, piccoli passi nella giusta direzione da parte di grandi brand hanno il potenziale di lanciare un segnale importante. Sempre H&M ha iniziato ad adottare politiche di sostenibilità sempre più evidenti, richiedendo che “tutti i fornitori che lavorano con [loro debbano] sottoscrivere il [loro] Impegno di Sostenibilità, che consiste in una serie di norme standardizzate relative a salari equi, buone condizioni di lavoro, benessere degli animali e molto altro”.

E allora anche il motto di Asos, “cambiando il nostro modo di acquistare in modo che i nostri clienti non debbano farlo”, non sembra poi del tutto sbagliato… eccetto che nel provare a deresponsabilizzare i clienti, i primi a dover fare attenzione a questi temi.
Chiaramente, un modello di business sostenibile non può dipendere dal fast fashion, che si basa sulla produzione e distribuzione di abbigliamento a basso costo in tempi molto rapidi, seguendo le tendenze più recenti della moda, sfruttando manodopera a basso costo e materiali economici. È un sistema progettato per massimizzare il profitto attraverso l’ottimizzazione della catena di fornitura e il consumo frequente da parte dei clienti.
Alternative sostenibili

Il primo pensiero per cercare un’alternativa è tipicamente rivolto al second-hand e al riciclo. Ovviamente, riciclare è una scelta migliore del gettare un capo usato, ma non è mai
possibile riassorbire tutto l’impatto della sua produzione iniziale. Perciò, la prima azione sensibile da parte nostra dovrebbe riguardare una riduzione degli acquisti.
Potremmo anche pensare che donare i propri capi inutilizzati sia una buona scelta. Il supporto a comiunità che si occupano di redistribuzione locale costituisce a mio parere una buona soluzione per ridare una seconda vita ai propri capi. Purtroppo, come evidenziato nel recente documentario “Buy Now” su Netflix, la maggior parte dei vestiti inviati in Ghana non è utile: con una popolazione totale di 30 milioni di abitanti, vengono inviati 15 milioni di nuovi (vecchi) capi, i quali finiscono con l’inquinare i nostri mari e, di conseguenza, quello che mangiamo.
A ciò si aggiunge il fatto che, purtroppo, al momento non esiste una tecnologia per riciclare completamente tutti i vestiti vecchi, o almeno per farlo evitando che questo costituisca solo un grande costo di produzione. Il risultato è che la maggior parte degli scarti di produzione, dei capi invenduti dai brand e di quelli non più utilizzati dagli utenti viene gettata…
Quella della moda costituisce così la seconda industria più inquinante al mondo, che produce più vestiti di quelli che ci servono e che non ha standard produttivi che faciliterebbero un riciclo più rapido e consistente dei materiali di capi non più utilizzati. Il coinvolgimento del pubblico sembra essere anche minore di quello relativo alle industrie del cibo e della cosmetica, per esempio, visto l’impatto meno diretto che l’industria della moda ha sul nostro corpo e sulle nostre abitudini (nonostante le ultime notizie sulla pericolosità dei capi di Shein).
Ovviamente, se la scelta fosse limitata ai brand di fast fashion, opteremmo per quelli che propongono alternative sostenibili. Per fortuna (o meglio, grazie a chi ci ha già pensato), esiste sempre una valida alternativa a questi brand, che riguarda piccole realtà con maggiore controllo sui propri processi produttivi, e che perciò riescono a mantenere le promesse di sostenibilità. Per noi, il supporto a una realtà locale ed etica di questo tipo è sicuramente la scelta più auspicabile, tenendo sempre a mente la scala decisamente minore rispetto a quella su cui agiscono i grandi brand.

Un importante strumento per questo motivo è fairtrade, utile per individuare cotone prodotto garantendo sostenibilità ambientale della materia prima all’origine e il rispetto delle persone che lavorano nella lunga filiera del tessile. Tale attenzione è necessaria per vari motivi: perché riduce l’impatto sull’ambiente, perché riduce l’inquinamento dell’ambiente, perché rispetta le persone.
Un’altra iniziativa, italiana, degna di nota è Rifò, realtà toscana di cui abbiamo già parlato e che si occupa direttamente di raccogliere tessuti (per ora, solo alcuni specifici) e di rigenerarli, recuperando una tradizione tessile che stava cadendo in disuso tramite il diretto coinvolgimento di artigiani locali.
E nella vita di tutti i giorni?
Esistono anche alcuni consigli relativi alle abitudini più quotidiane che possiamo iniziare a prendere in considerazione. Spesso queste vengono sottovalutate, ma possono fare la differenza in alcuni casi, nonostante il minimo sforzo per implementarle. Le approfondiremo in articoli futuri. Qui, per il momento, ci limitiamo a ribadire che, per contrastare gli attuali sprechi, l’inquinamento e i problemi sociali, dobbiamo tutti cambiare la nostra mentalità. La moda non è usa e getta, ma piuttosto un investimento a lungo termine. Dovremo consumare in modo più consapevole, pensando alle tre “r”: ridurre (i consumi e gli sprechi), riusare (i capi di seconda mano in buono stato), riciclare (quei capi per cui ciò è oggi possibile).
Detto ciò, come proposto all’interno dello stesso documentario Netflix da Eric Liedtke, ex Brand President di Adidas, la soluzione non dovrebbe provenire solamente dai consumatori, ma dai brand stessi. Il fine vita del prodotto è un problema lasciato al consumatore, con i grandi marchi che se ne deresponsabilizzano. E qui, il ruolo dei Governi e delle regolamentazioni diventa estremamente rilevante per poter apportare veramente un cambiamento significativo. Ma prima di pensare al fine vita dei prodotti, forse potremmo pensare a quanto veramente ci servano…
E tu come vedi queste scelte sostenibili da parte dei brand? Hai suggerimenti per aumentare la sostenibilità nella vita di tutti i giorni? Per non perdere gli ultimi aggiornamenti sulle nostre iniziative, articoli e tanto altro, ricordati di seguirci sui nostri canali social e di iscriverti alla nostra newsletter!
A presto,
Teo 🙂
- Aggiungerei anche “la discretizzazione su reticolo di una teoria di campo è l’unico modo noto a oggi per studiarla da principi primi in modo non perturbativo”, se solo sapessi cosa significasse. ↩︎
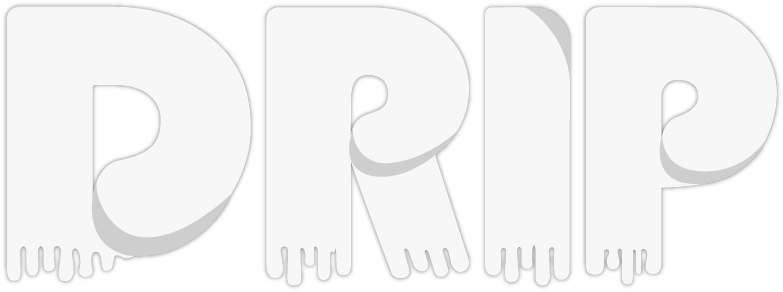
Lascia un commento